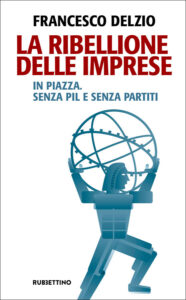Secondo voi, se gli italiani venissero posti di fronte alla necessità di scegliere, e non per gioco, tra Mario Draghi e Donald Trump, per quale dei due opterebbero? Dalla torre butterebbero giù chi attraverso la politica monetaria della Bce ha reso possibile e straordinariamente duratura una stagione di costo del denaro mai così basso, di cui l’Italia è stata la prima beneficiaria, oppure la spinta la darebbero al simbolo dell’America First, che ha rinunciato ad ogni forma non solo di multilateralismo ma persino di atlantismo e che vede nell’Europa un ingombrante concorrente commerciale oltre che un pezzo di mondo culturalmente lontano e ostile? Guardate che la domanda non è oziosa. E non solo perché la cronaca ci ha appena offerto lo spettacolo senza precedenti di un presidente degli Stati Uniti accusare (via tweet!!) il presidente della Bce di ordire una guerra valutaria al dollaro facendo concorrenza sleale sui cambi. No, in questo caso potrebbero avere ragione coloro che hanno derubricato questo inconsulto attacco di Trump come un parlare a nuora (Bce) perché suocera (Federal Reserve) intenda, visto che la Casa Bianca ha un contenzioso aperto con Jerome Powell (al quale, peraltro, viene imputata la colpa di non ridurre ulteriormente i tassi d’interesse, che invece è la scelta fatta e ribadita da Draghi).
Peccato, però, che questo teatrino monetario sia avvenuto proprio in coincidenza di altri due fatti di grande rilevanza. Il primo è l’annuncio di Draghi che il suo quantitative easing, cioè la politica monetaria espansiva, avrà vita lunga, ben oltre la sua presenza a Francoforte, e che la Bce continuerà a muoversi alla luce dell’ormai famoso “whatever it takes”. Un passaggio per nulla scontato – visto che mancano poco più di quattro mesi alla fine del mandato di Draghi, tanto che si fanno già i nomi dei possibili successori – il cui significato fondamentale è che l’Europa continuerà ad usare una politica di larga circolazione monetaria a tassi prossimi allo zero, che in questi anni di recessione prima e di stagnazione poi, successivi alla grande crisi finanziaria mondiale del 2008 e a quella europea del 2011, è stato l’unico strumento che ha consentito al Vecchio Continente, e all’Italia in particolare, di non affondare. Non ha risolto i nostri problemi strutturali – quelli spetta a noi metterci mano – ma ci ha consentito di comprare preziosissimo tempo, senza il quale ci saremmo trovati in condizioni “greche”. Peggio per noi, poi, se questo tempo lo abbiamo in larga misura sprecato, mostrandoci incapaci di usarlo per fare, nelle condizioni migliori possibili, quelle riforme strutturali che abbiamo sempre rimandato. Ecco perché quando il presidente della Bce (italiano, non dimentichiamocelo), sostiene che negli ultimi dieci anni il peso degli aggiustamenti macroeconomici “è caduto in maniera sproporzionata sulle spalle della politica monetaria” rispetto alle politiche economiche e fiscali degli stati membri dell’euroclub, è facile intuire che in primis, anche se non solo, si riferisca all’Italia.
Il secondo fatto rilevante cui ci riferiamo è la pompata visita a Washington del vicepremier (ma facente funzioni di premier) Matteo Salvini. La quale si rivelerà utile per il Paese se davvero rappresenta, come taluni si spingono a immaginare, la benedizione che il leader della Lega cercava per decidersi – finalmente – a mettere fine al governo Conte e al patto con i 5stelle. Viceversa, e quale che sia la ricaduta interna, quel viaggio sul piano strategico delle alleanze geopolitiche, questione ben più importante della contingenza nazionale, per l’Italia – purtroppo – non rappresenta il consolidamento della sua vecchia vocazione atlantista e neppure la nascita di un nuovo patto nel mondo occidentale, ma segna invece l’adesione ad una sorta di “internazionale sovranista” – certo, è una contraddizione in termini, ma è così – in cui gli interessi italiani vengono subordinati a quelli americani, sapendo che questi ultimi sono in netto contrasto con quelli europei. E l’incrociarsi temporale dei due accadimenti – l’attacco di Trump a Draghi e la “prima” di Salvini alla Casa Bianca – rende ancor più stridente il tutto. Specie se si considera che tale incrocio avviene nel quadro di una guerra commerciale in corso tra Stati Uniti ed Europa, che Trump pratica brandendo l’odiosa arma del protezionismo e dei dazi (li ha minacciati persino sul nostro prosecco). Guai, dunque, agli atti di sottomissione.
Ecco, come si vede, porsi il problema del “da che parte stare” non è affatto un gioco di società, come si concede di pensare una fetta non piccola della nostra borghesia adusa al semplicismo (certamente più quella che si alimenta con la rendita che non quella del profitto, ma ahinoi anche questa seconda). La politica estera, la collocazione strategica e le alleanze internazionali sono tratti fondamentali per qualunque paese, tanto più per il nostro che è “di frontiera” e non gode, sotto nessun profilo, dell’autosufficienza. A noi, come avrete capito, non sfiora neppure il dubbio di quale debba essere la sponda cui approdare: quella dell’Europa. Tanto più dopo aver visto le ragioni che militano per il fronte opposto. Prendete, tanto per fare un esempio, Marcello Veneziani: dopo aver detto, bontà sua, che la priorità atlantica (ma quella di Trump non ha titolo per definirsi così) non può schiacciare il legame con la tradizione europea e che per questo a lui piace Steve Bannon solo fino a un certo punto (mah), ci fa sapere però che è “bene Trump se ci aiuta a tenere a bada gli eurotromboni” e che comunque se la scelta è tra “The Donald” e “superMario”, lui sceglie Vladimir Putin. Ecco, se questa è la linea di discrimine…
Ma non è per caso o per usare un artifizio dialettico che abbiamo iniziato questo nostro ragionamento interrogandoci, e domandandovi, quale sarebbe l’esito di un ipotetico referendum “Draghi-Trump”. Il Paese su un punto così delicato ha il dovere, prima ancora che il diritto, di esprimersi. Per esempio, se Salvini si confermasse paladino del presidente-magnate americano, manterrebbe il vento in poppa di cui gode in questo momento, anche al costo di puntare la prua della nave Italia verso l’uscita dall’Europa, o piuttosto farebbe la stessa fine dell’altro Matteo, il Renzi, quando senza aver inteso quale fosse il vero sentiment nazionale si buscò la sconfitta del Sì alla riforma costituzionale, punto di partenza della sua rovinosa caduta politica? E i 5stelle, ammesso e non concesso che fossero capaci di una posizione unitaria su un tema così dirimente, sarebbero per la solidarietà europea o atlantica? O per non saper né leggere né scrivere starebbero dalla parte del cinese Xi Jinping e della sua “via della seta”? E le opposizioni – di cui ci siamo poco occupati, visto che i loro processi interni somigliano più a dei contorcimenti con relativi regolamenti di conti, che a dei travagli, pur tormentati, di ridefinizione del proprio modo di essere e della linea politica – sono in grado di mettere in campo qualcosa che vada al di là del puro e semplice riflesso condizionato dell’essere per definizione contro le altrui posizioni?
Nell’atto stesso di formularli, questi interrogativi, ci accorgiamo che trattasi in buona misura di domande retoriche, di cui sappiamo già la (deludente) risposta. In realtà, quella che va interrogata è la cosiddetta società civile. E in particolare le sue articolazioni organizzate, i corpi intermedi. È da lì che deve partire, se c’è – e noi vogliamo continuare a credere che ci sia – la risposta più ferma al pericolo che il Paese possa finire fuori dall’Europa e dall’eurosistema, o che continui a starci ma sullo strapuntino, ospite indesiderato. Sono gli imprenditori, grandi e piccoli o anche solo individuali, e i lavoratori, subordinati e non – cioè le categorie che più di tutte la altre pagherebbero il prezzo maggiormente oneroso di scelte sbagliate – che devono dire da che parte intendono stare. E possibilmente insieme, come suggerisce un bel libro di Francesco Delzio (“La ribellione delle imprese. In piazza. Senza PIL e senza partiti”, Rubbettino), il quale nell’intervista che Terza Repubblica gli ha fatto (la trovate QUI) arriva a ipotizzare una manifestazione indetta da Confindustria e sindacati congiuntamente. La posta in gioco è troppo perché qualcuno si possa concedere il lusso di stare a guardare.
Altre Rassegne
- affaritaliani.it 2020.09.01
La ribellione delle imprese, Francesco Delzio: “Coronavirus, imprenditori e lavoratori mai così vicini”
di Micaela Longo - SkyTG24 2020.06.04
Francesco Delzio ospite di SKYLINE (SkyTG24) - magazine.tipitosti.it 2019.12.09
Francesco Delzio: Cercasi un partito del Pil - lettera43.it 2019.11.19
L’intervista a Francesco Delzio a Roma InConTra - SkyTg24 2019.11.14
La Ribellione delle Imrpese (evento Confcommercio su SKY TG24) - Billy - Tg1 2019.10.13
La ribellione delle imprese
di Bruno Luverà - Giornale di Sicilia 2019.10.13
I mutamenti economici oltre i luoghi comuni
di Antonio Calabrò - Corriere Imprese Nordest (Corriere del Veneto) 2019.09.09
Delzio (Atlantia) e la ribellione del mondo produttivo in un’Italia contagiata dal virus anti-industriale
di Massimiliano Melilli - Robinson (La Repubblica) 2019.08.31
Attualità / Aziende e sindacati insieme in piazza - SKY 2019.08.07
Intervista a Francesco Delzio
di SkyTg24 - La Provincia 2019.08.05
«Imprenditori, ribellatevi!» La piazza per salvare il paese
di Enrico Marletta - Italia Oggi 2019.07.31
Contrattazione più libera
di Edoardo Massimo Fiammotto - Formiche 2019.08.01
Recensione - Formiche 2019.08.01
Recensione - Mediaset 2019.07.26
Intervista a Francesco Delzio a ‘La Lettura’
di Tg5 Notte - Il Venerdì - La Repubblica 2019.07.26
Imprese versus populisti
di Massimiliano Panarari - Sette (Corriere della Sera) 2019.07.26
«Scioperare, però insieme»
di Rita Querzè - Lamescolanza.com 2019.07.22
Da leggere l’ultimo libro di Delzio “La ribellione delle imprese”
di Romina Nizar - Gazzetta del Mezzogiorno 2019.07.21
L’inquietudine delle imprese dimenticate dalla politica
di Michele De Feudis - SkyTg24 2019.07.04
In un pamphlet edito da Rubbetino il manager di Atlantia traccia alcune vie di uscita per ridare centralità a una figura che rischia l’emarginazione sociale
di Filippo Maria Battaglia - VanityFair 2019.07.10
Tutti in piazza appassionatamente
di Laura Pezzino - affariitaliani.it 2019.07.03
“La ribellione delle imprese”, Delzio presenta il suo nuovo volume - Giorno/Resto/Nazione 2019.07.02
La rivolta delle imprese anti populismo
di Achille Perego - Huffingtonpost.it 2019.07.01
Imprenditori e lavoratori, piazza San Giovanni vi aspetta
di Gianni Del Vecchio - msn.com 2019.06.27
Il salto di Quaglia e Delzio anti-governativo
di Andrea Copernico - Il Messaggero 2019.06.27
La nuova “ribellione” delle imprese sarà contro populismi e spinte demagogiche
di Umberto Mancini - La Sicilia 2019.06.24
Imprenditori e lavoratori uniti nella lotta al Governo
di Enrico Cisnetto - paolopoliti.blog 2019.06.21
L’atto di sottomissione di Salvini a Trump e l’attacco Usa a Draghi. Bisogna decidere da che parte stare - Il Gazzettino 2019.06.23
Investitori scoraggiati da tasse e burocrazia
di Enrico Cisnetto - terzarepubblica.it 2019.06.20
Imprenditori ribelli
di Marco Dipaola - Rai 2019.06.17
Francesco Delzìo ospite ad Agorà con “La ribellione delle imprese” - La7 2019.06.17
Francesco Delzìo ospite a L’Aria Che Tira con “La ribellione delle imprese” - Corriere della Sera 2019.06.14
Il partito del Pil ora è in cerca della piazza
di Dario Di Vico - Il Sole 24 Ore 2019.06.14
Imprenditori italiani emarginati nell’epoca del populismo
di Francesco Delzìo