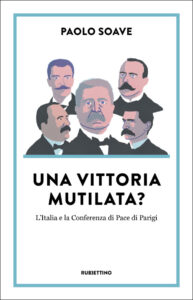Il tema della “vittoria mutilata” è stato affrontato da vari storici italiani, ma quasi sempre nel contesto più ampio di opere dedicate alla storia della politica estera liberale e fascista o alla crisi finale dell’Italia liberale. Un’opera organica sul tema fu avviata molti anni fa dal Maria Grazia Melchionni, ma, di fatto, i principali riferimenti storiografici restano il volume di Burgwyn dei primi anni ’90, eloquentemente intitolato The Legend of the Mutilated Victory, e la più datata opera di Albrecht-Carrié sull’Italia alla conferenza di Parigi. Non sorprende, pertanto, che la vulgata storiografica ancor oggi prevalente a livello internazionale sia quella che liquida la “vittoria mutilata” come una chiara manifestazione di quel nazionalismo immaturo, tipico di un Paese incompiuto tanto a livello sociale che politico, che perseguì con l’ingresso in guerra interessi egoistici e eccessivi, con un appetito superiore alle capacità digestive del Regno, come sostennero alcuni osservatori alleati.
Questa lettura affonda le proprie radici negli ambigui rapporti intessuti dall’Italia con gli alleati e con gli Stati Uniti fino alla conferenza di pace, con relazioni che, come ha scritto Luca Riccardi, non furono mai di autentica amicizia, né dettero vita a un’ alleanza alla pari, come ha rilevato Burgwyn parlando di mésaillance, un ménage fra appartenenti a classi sociali diverse. Alle incomprensioni di guerra si aggiunsero le innumerevoli testimonianze critiche di coloro che parteciparono ai negoziati parigini, da Clemenceau a Tardieu, da Lloyd George a Nicolson, solo per citare i più noti. Tutti concordarono sul fatto che l’Italia nutrisse ambizioni superiori ai propri meriti di guerra e alle proprie possibilità. In definitiva, nessuno fu disposto a riconoscere al Regno l’acquisito status di grande potenza, né a responsabilizzarlo con compiti strategici in ambiti geopolitici specifici.
Il ragionamento storiografico si completa attribuendo gravose responsabilità a quella classe dirigente che decise di portare il Paese in guerra sulla base di aspettative irrealistiche, capaci solo di infiammare un nazionalismo esasperato che ebbe in D’Annunzio ispiratissimo cantore e comandante. La “leggenda della vittoria mutilata” trovò credito anche in Italia, in particolare fra le file di coloro che presero le distanze dalla politica estera di Sonnino e che avrebbero preferito un autoridimensionamento dell’Italia al rango di dimessa ancella degli Stati Uniti, anche per sventare l’incombente minaccia bolscevica. Con sfumature diverse questa fu la posizione di Bissolati e Nitti, che lasciarono il governo, e di Salvemini, il quale fornì ai teorici della “leggenda della vittoria mutilata” l’elemento finale e risolutivo, ovvero la presunta saldatura fra gli errori commessi a Parigi dalla delegazione italiana e l’avvento del fascismo. Come noto Salvemini si spinse a sostenere un legame strettissimo fra la “vittoria mutilata” e il fascismo, legittimato, condizionato e infine schiacciato da quella delusione nazionalistica.
Per fortuna la storiografia internazionale sulla Grande Guerra e sulla successiva pace, in costante evoluzione, ha nel tempo demolito questa lettura mattone dopo mattone cominciando dal riconoscere il contributo italiano alla vittoria alleata e i gravi limiti delle deliberazioni parigine. Le condizioni interne del Regno d’Italia erano certo diverse da quelle degli alleati, i quali nondimeno assunsero a Londra, nell’aprile 1915, impegni sulla base dei quali fu possibile costruire quel vincolo nazionale di sangue che portò all’ingresso nel conflitto di un Paese riluttante. Se indubbiamente nel corso delle ostilità le condizioni internazionali mutarono radicalmente, fu anche per un preciso calcolo di interessi da parte degli anglo-francesi, che si vincolarono in senso ostile all’Italia e decisero di privilegiare altri partner, in un primo momento la Russia, poi il Regno dei serbi, dei croati e degli sloveni, e la Grecia. Le partizioni delle ex colonie tedesche, dell’Asia Minore e del Medio Oriente ne furono l’evidente dimostrazione.
Nel corso della conferenza di Parigi venne fatta gravare sulla delegazione italiana, come sostiene Soave, nell’innovativo volume, Una vittoria mutilata? L’Italia e la Conferenza di Pace di Parigi, appena edito, presso Rubbettino Editore nelle collana “dritto/rovescio”, diretta da Eugenio Di Rienzo (pp. 157, euro 14,00), ogni sorta di pressione, da quella puramente diplomatica, nella forma dell’isolamento dagli altri vincitori, a quella finanziaria. Wilson, che come ricorda Soave era stato accolto in Italia dalla più entusiastica delle opinioni pubbliche, dimostrò di considerare il Regno come un interlocutore politicamente incompiuto, non realmente democratico, sul quale sarebbe stato possibile operare pressioni impensabili nei confronti di Francia e Regno Unito. Lloyd George e Clemenceau ebbero pertanto buon gioco nel dichiararsi impotenti di fronte alla leadership esercitata dal presidente statunitense, che consentì loro di eludere gli impegni assunti a Londra e di ammonire l’Italia che una rottura dei negoziati di pace avrebbe potuto condannare il Regno a un dopoguerra di fame.
Il nazionalismo più tossico che circolò nel corpo del Paese non fu pertanto quello inoculato da D’Annunzio, destinato a perdere rapidamente la propria tossicità all’esaurirsi dell’impresa fiumana, quanto quello letale di una Nazione che dopo aver sostenuto uno sforzo immane si scoprì ricaduta in una condizione sociale peggiorata e sul piano internazionale ancor più dipendente dalle potenze maggiori. Se lo sbocco simil-bolscevico tanto annunciato non si realizzò, fu perché come sostenne Lenin l’unico rivoluzionario italiano era D’Annunzio, marginalizzato dall’azione politica di Mussolini. Infine appare significativo il rapporto del tutto strumentale che il capo del nascente fascismo sviluppò nei confronti della “vittoria mutilata”, utile più a delegittimare la classe liberale che a orientare la futura politica estera italiana, al punto che Mussolini si espresse in un primo momento a favore del trattato di Rapallo.
Come il fascismo non scaturì dalla “vittoria mutilata”, ma da tensioni ben più profonde e diffuse nel corpo sociale e nazionale del Paese, analogamente la delusione italiana per le deliberazioni parigine non fu la fatale conseguenza degli errori della delegazione, condizionata dalle mosse estemporanee di Orlando e dalla rigidità di Sonnino, quanto la conseguenza dall’imporsi degli interessi geopolitici anglo-francesi e dell’astratta visione wilsoniana. Questa in particolare risultò essere un corpo estraneo innestato nella tradizione politico-diplomatica europea capace di affermarsi solo a spese dei vinti e dei vincitori minori, come l’Italia.
Il libro di Soave colma la lacuna storiografica di una visione organica della “vittoria mutilata”, rettifica le interpretazioni squilibrate dei vincitori maggiori della Grande Guerra e ricorda come quella che negli estenuanti negoziati parigini fu considerata, con fastidio, l’azione di disturbo italiana, costituì una delle tante occasioni mancate della conferenza per conferire agli assetti postbellici quella solidità che sarebbe drammaticamente mancata.
Altre Rassegne
- storiainrete.com 2021.03.01
«La Vittoria mutilata»: uno slogan che si è avvicinato alla verità
di Guglielmo Salotti - storiainrete.com 2021.03.01
«La Vittoria mutilata»: uno slogan che si è avvicinato alla verità
di Guglielmo Salotti - indygesto.com 2020.07.11
La rabbia dopo la vittoria: la «vittoria mutilata» secondo Paolo Soave
di Lorenzo Terzi - storiainrete.com 2020.12.15
1919: i peggiori nemici sono i tuoi alleati. L’Italia e la Vittoria “mutilata”
di Marco Valle - blog.ilgiornale.it 2020.12.15
Parigi 1919. Una vittoria mutilata
di Eugenio Di Rienzo - ereticodisiena.it 2020.09.06
La domenica del villaggio: Daverio, Radicofani, “vittoria mutilata” - nuovarivistastorica.it 2020.07.13
Italy, the Real Great Powers and the Conference of Paris in 1919. A “mutilated victory”?
di Richard James Boon Bosworth - Il Giornale 2020.07.10
La vittoria mutilata non era un mito ma la dura realtà che cambiò tutto
di Giampiero Berti - Il Quotidiano del Sud 2020.07.10
Gli accordi di Parigi un errore strategico
di Luigi Morrone - Robinson (La Repubblica) 2020.07.04
Mai umiliare le Nazioni sconfitte
di Stefano Folli - giornaledistoria.net 2020.07.01
Recensioni / Una vittoria mutilata? L’Italia alla Conferenza di Pace di Parigi del 1919
di Luca Riccardi - loccidentale.it 2020.06.29
Storia e cronaca di una vittoria mutilata
di Marcello Rinaldi