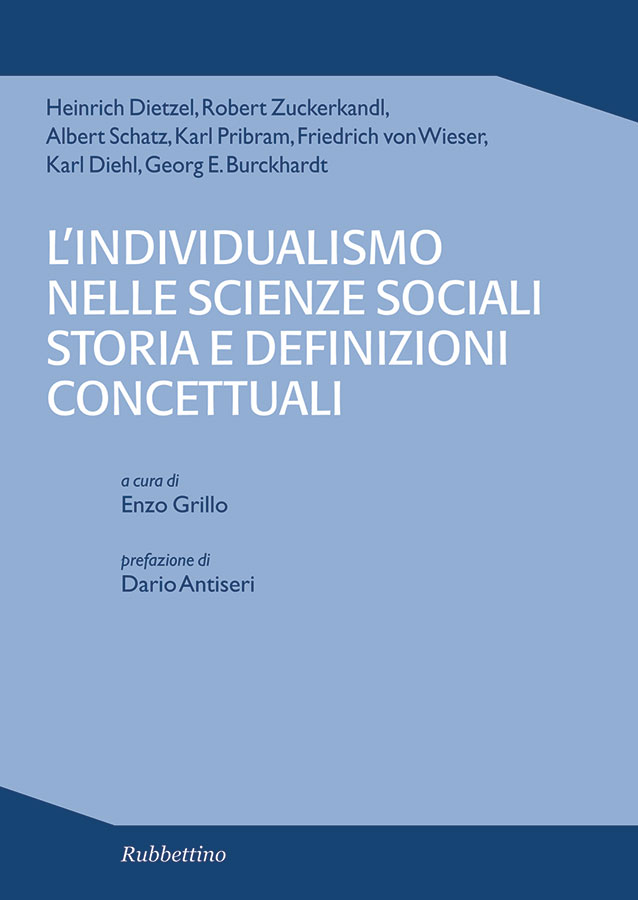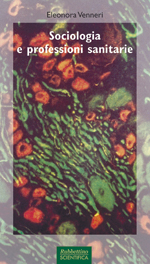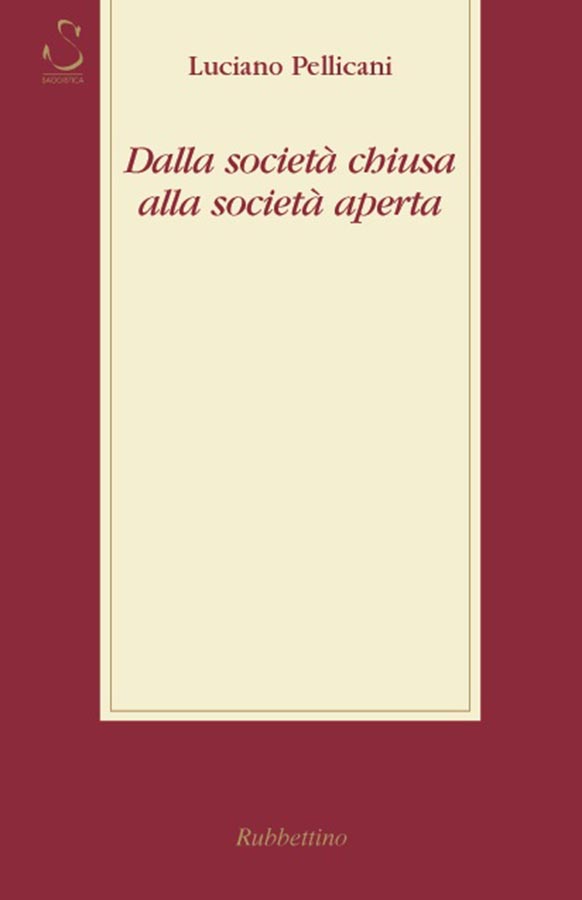Fare moltitudine
Cartaceo
€4,94 €5,20
Il discorso che tenterò di affrontare riguarda i vari modi in cui si possono articolare i rapporti tra singolarità e comune. Questo significa ovviamente individuare precisamente il significato che è possibile attribuire a questi
Il discorso che tenterò di affrontare riguarda i vari modi in cui si possono articolare i rapporti tra singolarità e comune. Questo significa ovviamente individuare precisamente il significato che è possibile attribuire a questi termini, ma anche verificare come da singolarità e comune possa derivare un terzo termine, quello di moltitudine. Vorrei allora che il concetto di moltitudine fosse allo stesso tempo il nostro punto di partenza e il nostro punto di arrivo, e che ci obbligasse a percorrere a ritroso alcuni momenti della storia del pensiero moderno, per poter fondarne la consistenza attraverso la critica di una tradizione politica nella quale sembriamo tutt’ora immersi.
Non si tratta in realtà di un semplice problema di descrizione empirica della moltitudine. Negli ultimi anni, da Seattle in poi, ovunque si danno moltitudini: insiemi colorati, disparati e nonostante tutto coesi, ad ogni modo poco assomiglianti a tutte le vecchie forme di organizzazione alle quali eravamo abituati. Il problema, semmai, è quello di provare a pensare teoricamente il modo in cui fare moltitudine, vale a dire sia l’articolazione intima della moltitudine, la sua aggregazione, che le sue condizioni esterne di possibilità, le sue determinazioni. Ed è qui che l’interrogazione reciproca sui rapporti tra singolarità e comune può essere importante.
Dal ‘600 in poi, ci sono due serie di istanze che vanno a determinare una tensione che sarà alla base del pensiero politico moderno. Due serie, perché i termini che le compongono, pur rappresentando lo stesso tipo di taglio epistemologico e politico, ed essendo spesso scambiati per sinonimi, non sono in realtà equivalenti. La prima serie comprende per esempio la persona, l’individuo, il cittadino, il singolo, e cioè tutte le figure del particolarismo con le quali s’identifica un uomo in quanto è uno, il non universale assoluto o, in una certa misura, il sé. La seconda serie comprende, invece, le figure del popolo, della popolazione, della folla, della massa e, in seconda battuta, dell’associazione, della società, o della comunità. Data questa premessa, l’ipotesi che io proverò a formulare è che, dal ‘600 in poi (grosso modo da Hobbes in poi) queste due serie sono state giocate l’una contro l’altra solo per poter paradossalmente essere intimamente intrecciate; e che da tale articolazione è nata la definizione politica di ciò che può essere la forma e l’ambito di incidenza del contrattualismo e delle teorie della rappresentanza politica.
La presa in considerazione di queste due serie costruite l’una contro l’altra in una tensione da cui, tuttavia, deriva non solo la possibilità del loro intreccio ma l’invenzione di uno spazio politico e sociale nel quale viviamo, o perlomeno abbiamo pensato di vivere fino a poco tempo fa, delimita dunque il nostro campo d’indagine. Poniamo fin da ora la domanda che ci guiderà tra poco: perché il concetto di moltitudine viene squalificato da questo spazio politico, se non addirittura espulso da una griglia concettuale che non lo prevede? Quale pericolo la modernità vede nel concetto di moltitudine, per rifiutare di vederlo se non come sinonimo dei molti, vale a dire sotto la forma dell’informe (se non del deforme), della non-definizione politica, del pre-politico?
C’è un passo dedicato alla disciplina, nel capitolo terzo di Sorvegliare e punire, in cui Foucault, invece di separare ciò che è dell’ordine dell’individuale o del particolare e ciò che è dell’ordine del collettivo, descrive queste due serie – individuale e collettivo – come due dispositivi di potere che, fin dal principio, si costruiscono insieme. Quello che vorrei dunque provare a mostrare è che l’opposizione tra individuale e collettivo, o se volete, tra individuo e società, o ancora tra singolarità e associazione, è per Foucault la riproduzione sul piano politico e sociale di un binomio della stessa forma di quello che egli descrive quando individua i rapporti tra ragione e disragione: un binomio che si costruisce sotto la modalità esauriente e pervasiva del medesimo e dell’altro, vale a dire come una struttura duale, che pretende di coprire interamente lo spazio dei saperi e dei poteri senza resto alcuno, senza esteriorità possibile. In questo senso, allora, tutta la rappresentazione del politico e tutto il vocabolario politico di cui noi tutt’ora disponiamo, oggi sarebbero totalmente legati a un’origine classique. O, per dirla altrimenti, non solo la nostra rappresentazione del politico sarebbe epistemologicamente determinata dal moderno – cosa in sé abbastanza palese –, ma la forma che contraddistingue per eccellenza la politica moderna – lo Stato – sarebbe la trasposizione della ragione su un piano specifico dell’epistem, che integra i suoi strumenti successivi e i suoi dispositivi: la disciplina, il controllo, i biopoteri.
Il dualismo ragione/disragione possedeva la peculiarità di riuscire a controllare e mettere in ordine il reale nella sua totalità, nella misura in cui nulla poteva scappare alla pretesa tassonomica razionale, neanche il suo negativo, il disragionevole. In questo, l’età moderna segnava il trionfo della Ratio, nella scoperta paradossale che il suo opposto – ciò che apparentemente le sfuggiva, ciò che non ne faceva parte, ciò che non rispettava i suoi codici – era ad ogni modo una parte di sé, anzi, il suo strumento di potere migliore. Escludendo la disragione da sé, la ragione scopriva di poter al contempo includerla, sottoporla al suo potere, gestirla, cancellarne i pericoli, usarla.
Torniamo allora al nostro problema. L’opposizione tra individuale e collettivo, o più generalmente tra particolare e universale, viene tradotta politicamente attraverso questa quadratura del cerchio che la modernità deve risolvere: trovare una forma politica in cui l’interesse dell’individuo singolare – in quanto tale pericoloso perché non universale, e quindi necessariamente minaccioso delle libertà altrui – possa essere incluso dentro un interesse generale, un interesse dunque non più singolare ma collettivo. Questo collettivo viene definito integrando esplicitamente entrambi i termini dell’opposizione: è collettivo ciò che non è di nessuno e perciò è di tutti: come se, in questo gioco tra uno e tutti, fosse all’opera la stessa strana struttura duale inclusiva/esclusiva (inclusiva perché esclusiva) che sanciva il potere assoluto della Ragione.
Ora nello stesso momento in cui scrive Foucault, a metà degli anni ‘60, un altro filosofo francese, Jacques Derrida, a partire da presupposti filosofici assai diversi, critica fortemente tutta una serie di opposizioni concettuali classiche, leggendovi la morsa assoluta del Logos occidentale sul reale, e il suo tentativo di coprire e di controllare interamente lo spazio del pensiero.
Mi sembra che nelle analisi di Derrida, apparentemente nate all’epoca come totalmente estranee alla dimensione del politico – anche se in realtà il tema s’imporrà da sé quasi dall’inizio – vale a dire in ambito prima fenomenologico e successivamente linguistico, vi sia l’idea che viviamo dentro un pensiero metafisico. Questa metafisica – che non è altro che il Logos occidentale, la grande “mitologia bianca” secondo la bella espressione di Derrida – è precisamente costruita, articolata, imperniata a partire da un certo numero di elementi, alcuni dei quali molto astratti altri, invece, molto concreti e immediati; ora, dal punto di vista linguistico, dice Derrida, uno di questi è la strutturazione e la sedimentazione del pensiero a partire da un certo numero di binomi concettuali che prendono la forma di coppie di opposti: essere/non essere, medesimo/altro, parte/tutto, particolare/universale, individuale/collettivo ecc. Il metodo derridiano comincia proprio con la decostruzione di queste opposizioni che, avendo la pretesa di coprire assolutamente lo spazio del pensiero, si presentano assai affini alla struttura di chiusura assoluta descritta da Foucault per caratterizzare il funzionamento epistemico dall’âge classique in poi.
Mi interessa avvicinare Foucault e Derrida non perché parlino della stessa cosa – e, infatti, il primo svolge un’inchiesta storica (archeologica) mentre il secondo affronta il problema in modo concettuale e essenzialmente a-storico – ma perché mi sembra che la questione sia ancora quella del dualismo nel segno della metafisica: del duale come segno della metafisica.
Ciò premesso, la tesi che vorrei provare a formulare è che il concetto di cittadino, così come è stato elaborato dal pensiero politico moderno, è la risultanza esatta, il prodotto perfetto della tensione tra individuale collettivo, vale a dire il nodo di un dualismo oppositivo diventato struttura inclusiva assoluta, potere assoluto sul reale; stando al discorso di Foucault, ciò significa che il concetto di cittadinanza e la figura stessa del cittadino sono stati costruiti da un meccanismo disciplinare che caratterizza il potere moderno. Per questo motivo, vorrei adesso tornare sul capitolo terzo di Sorvegliare e punire.