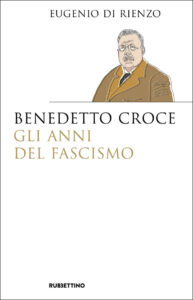Molto si insiste ancora sulla validità della definizione del fascismo come breve e transeunte «parentesi» della vita politica italiana, priva di ogni nesso di continuità con la storia dell’Italia liberale, formulata a più riprese da Benedetto Croce dopo il 25 luglio 1943. Senza considerare che la formula, adottata dal filosofo, «falsissima in sede storiografica» avrebbe detto Eugenio Garin, andava intesa alla stregua di uno slogan strumentale (un vero e proprio «uso politico della storia»), adatto al tempo e all’ora, ma proprio per questo incapace di fornire un contributo alla definizione storiografica del fascismo come evento storico.
L’assimilazione del fascismo all’«invasione degli Hyksos con la sola felice differenza che la barbarie di questi durò in Egitto oltre duecento anni, e la goffa truculenza fascista si è esaurita in poco più di un ventennio», si scontrava, infatti, con la cruda evidenza, dolorosamente constatata da Croce per diretta, sofferta esperienza, che quel regime fu immediatamente accolto da un consenso vasto, duraturo e pressoché incontrastato a cui solo il netto profilarsi della catastrofe militare pose fine nella seconda metà del 1942.
Il travaso di consensi dal sistema parlamentare statutario a un governo d’emergenza, che fin dai suoi primi passi aveva mostrato i suoi lineamenti violenti, oppressivi, autoritari se non immediatamente dittatoriali, fu soprattutto forte da parte degli intellettuali liberali e dei loro gruppi politici di riferimento, stremati dalle fiacchezze e dai compromessi del sistema giolittiano e dalla deriva politica e sociale del primo dopoguerra che il governo Nitti aveva dimostrato di non sapere arginare. Anche Croce, se non fu davvero «uno schietto fascista senza camicia nera», come gli rinfacciò Giovani Gentile, pure rimase vittima di quell’illusione, fino al gennaio 1925, pagando nel giudizio dei contemporanei e poi degli analisti del passato un alto prezzo per quel fallo.
A tale riguardo basti ricordare la severa sentenza di Giuseppe Antonio Borgese, un liberale che fin dall’inizio dell’avventura fascista rimase fermo nei suoi convincimenti, senza prestare ascolto agli iniziali messaggi rassicuranti dell’uomo di Predappio, il quale nel suo Goliath, the March of Fascism, pubblicato, a New York, nel 1937, pur accordando al filosofo napoletano delle attenuanti, pur riconoscendogli qualche merito antifascista, giudicava «logica l’adesione di Gentile al fascismo e teoricamente contraddittoria l’avversione di Croce». E questo perché «se il sistema intellettuale del neo-idealismo, con la sua identificazione del reale con l’ideale, non portava teoricamente a nessuna obiezione fondamentale alla realtà del fascismo, Gentile, come filosofo, fu davvero più coerente di Croce e la sua accettazione del fascismo, dialetticamente, hegelianamente, non fa una grinza». Giudizio che può sembrare sommamente ingiusto e ispirato ad estrema malevolenza e frutto di pregresse rivalità letterarie personali (che certo, tra i due, non mancarono), ma che, invece, era per molti versi fondato e sensato e che Borgese esplicitava in un altro passo del suo volume.
Nell’elegante mondo intellettuale, che coincise con gli anni di formazione di Croce, era regola irridere la democrazia, il liberalismo snervato e troppo tollerante, il socialismo riformista, mansueto, sentimentale, accomodante e rinunciatario, che era da molti considerato un sottoprodotto della peggiore democrazia borghese. Croce stesso che, per molti aspetti, era superiore a tutti gli altri, aveva rinunciato al socialismo della sua giovinezza, dandosi a qualcosa di molto simile al torysmo politico ed economico, o a un ferrigno liberalismo socialmente conservatore, cosa comprensibile in lui, proprietario di terre e nipote di Silvio Spaventa.
Nella Filosofia della pratica, pubblicata nel 1909, egli sostenne la teoria machiavellica del potere e dello Stato e inserì anche una apologia teorica della Santa Inquisizione – che era veramente santa, come lui, non cattolico, sosteneva – considerandola un uso inevitabile e filosoficamente legittimo della violenza nella politica. Circa nella stessa epoca, Croce pubblicò una traduzione italiana delle Riflessioni sulla violenza di Sorel, accompagnandola da una prefazione molto lusinghiera e cercando di diffonderla con tutti i mezzi pubblicitari a sua disposizione, proprio perché in quell’opera l’autore privava il socialismo di quel poco di sentimento umanitario, ereditato dalla philosophie settecentesca, trasformandolo in un sogno di sovvertimento universale che egli chiamò sollevamento religioso o rinnovamento, sindacalismo o mito creativo dello sciopero generale. A Croce non poteva non piacere molto Sorel, infatti, per il valore morale che egli vedeva nell’opposizione radicale di quest’ultimo all’ottimismo, al pacifismo, alla morale umanitaria e a tutto gli altri ideali da pochi soldi della “mentalità del diciottesimo secolo”, che Croce odiò sempre e non smise mai di odiare di tutto il suo cuore.
Mussolini, ancora attaccato all’idea che nel socialismo rivoluzionario avrebbe trovato la via del successo, tardò a seguire i neri dettami pratici più o meno indirettamente impliciti in quelle tendenze nerastre. Ma, infine, lo fece e non v’è dubbio che prese, tanto da Pareto e Sorel, tanto da D’Annunzio e Nietzsche, quanto da Croce, gli argomenti di cui aveva bisogno sia per la sua lotta contro il debole socialismo e il liberalismo contaminato dai dogmi enfatici dell’Illuminismo sia per alimentare il suo odio contro i compromessi, la mentalità massonica, i semiborghesi della politica socialista e i borghesi di quella giolittiana. Poi Mussolini dimenticò Croce o finse di dimenticarlo: cosa che non ci sorprende perché egli era capace di ricordare o di voler ricordare solo ciò che si adattava ai bisogni immediati della politica politicante.
Il nuovo libro di Eugenio Di Rienzo, Benedetto Croce. Gli anni del fascismo (Rubbettino Editore), che fa seguito ad un suo precedente saggio consacrato al difficile arco temporale 1943-1948 vissuto dal direttore de «La Critica», è dedicato proprio al confronto pratico-politico e teorico di Benedetto Croce con il Ventennio nero e costituisce una seconda tappa di avvicinamento alla composizione di una biografia integrale del filosofo. In questa nuova prova, Di Rienzo non fa tabula rasa del giudizio di Gentile e di Borgese su Croce (da lui debitamente citato) e di altre valutazioni ancora più sferzanti ma si sforza, con successo, di guardare più in là, e cioè a Croce nel fascismo dopo la fine della sua fascinazione per il fascismo.
Di fondamentale importanza, infatti, fu, secondo Di Rienzo, l’esperienza del fascismo per l’itinerario intellettuale del filosofo. Soltanto in seguito al suo passaggio da convinto simpatizzante del movimento mussoliniano (considerato l’unico ingrato rimedio allo stato di anarchia permanente che soffocava il nostro Paese) a inflessibile oppositore del regime, la sua riflessione politica, che aveva a lungo oscillato tra la lezione di Marx, una tiepida e fuggevole simpatia per l’ideologia socialista, il pensiero anti-sistema di Georges Sorel, il legato dei teorici tedeschi dello «Stato potenza» ebbe, soprattutto nel decennio 1928-1938, la sua svolta decisiva. Dopo il ritorno, successivo al 1919, alla piena accettazione della versione autoritaria del liberalismo ottocentesco mutuata dall’eredità della Destra storica, quel pensiero, infatti, iniziò a chiarirsi, a far data dalla metà degli anni Venti, nei suoi tratti distintivi per dare luogo a un «nuovo liberalismo».
Sarebbe stato quello un liberalismo diverso da quello del «mondo di ieri», per dirla con Stefan Zweig, ma proprio per questo in grado di fronteggiare la sfida dei totalitarismi del Novecento (quello fascista e quello comunista), diversi nelle loro premesse ideologiche ma egualmente avversi al vivere civile delle società occidentali, alle loro istituzioni politiche e alla loro tavola di valori morali. Molto prima della comparsa del volume di François Furet, Le passé d’une illusion, edito nel 1995, Croce, infatti, aveva compreso perfettamente che se tutti i liberali, tutti i democratici e molti conservatori, durante la dittatura del fascio littorio e della svastica, furono antifascisti, non tutti gli antifascisti, in quello stessa congiuntura storica, furono liberali o democratici.
Il lavoro di Di Rienzo che nell’analizzare uno dei momenti più tormentati e complessi della vita di Croce, alla ricerca di una difficile sintesi tra il suo pensiero e la sua azione, ha valorizzato, come si accennava, anche le prese di posizione dei suoi critici, dai più severi (Borgese, lo si è visto, Giorgio Levi Della Vida, Gaetano Salvemini, Guido de Ruggiero, Guido Calogero, Norberto Bobbio) ai più dialoganti (Luigi Salvatorelli, Gobetti, Corrado Barbagallo, Carlo Antoni, Eugenio Garin), potrà forse non piacere a chi preferisce eternare l’immagine stereotipata di un intellettuale, liberale da sempre o forse addirittura liberal, demiurgo di un sistema filosofico dove tout se tient. Di Rienzo pensa, infatti, che l’itinerario intellettuale di una grande filosofo deve essere analizzato nelle sue luci e nelle sue ombre, nei momenti alti e in quelli della caduta, arrivando a storicizzare anche i progressi del suo pensiero e mettendo in evidenza le inevitabili fratture che le congiunture esterne arrecarono alla sua compattezza e alla continuità della sua elaborazione.
Di questo naturalmente Di Rienzo è ben consapevole, senza però temere le critiche che verranno, forte proprio dell’affermazione di Croce il quale sosteneva che «la teoria dialettica o liberale della storia non deve porre a misura della storia un ideale trascendente ma la storia stessa» realisticamente e persino impietosamente investigata. L’autore di Benedetto Croce. Gli anni del fascismo riporta doverosamente all’attenzione della riflessione storiografica, senza lacune e senza censure, il periodo forse più discusso e più discutibile ma anche più intenso dell’intera biografia politica dell’ospite di Palazzo Filomarino. L’esperienza epocale del fascismo, infatti, spinse Croce, tra 1930 e 1938, (la fase peraltro creatrice delle sue opere più significative), a mettere in moto un progressivo e profondo ripensamento delle proprie convinzioni storiche e filosofiche, iniziato già dopo il 1925, la cui articolazione, guardando proprio al rapporto dialettico fra teoria e prassi, fra l’uomo di pensiero e l’uomo di azione (anche sul piano politico), non può essere colta senza un’analisi spregiudicata e di ampio respiro.
Del resto, come intellettuale e come promotore di cultura – ruoli dai quali, nonostante tutte le difficoltà, non avrebbe mai abdicato nel corso del Ventennio, tanto da divenire il capofila dell’opposizione interna alla dittatura – il filosofo si trovò a misurare in prima persona, nello spazio marginale consentito dal regime ad una libera azione politica e civile, il significato tutt’altro che astratto di una sua lucida formulazione teoretica, espressa nel 1938: «Veramente complicato e delicato è il processo dialettico onde il pensiero storico nasce da un travaglio di passione pratica, lo trascende liberandosene nel puro giudizio del vero, e, mercé di questo giudizio, quella passione si converte in risolutezza di azione».
Altre Rassegne
- francescomacri.wordpress.com 2021.03.04
Storia del Novecento. Fascisti e antifascisti contro Benedetto Croce
di Franco Cardini - Avvenire 2021.03.03
Fascisti e antifascisti contro Don Benedetto
di Franco Cardini - indygesto.com 2021.02.25
Quando Croce appoggiò il fascismo - Il Giornale 2021.02.20
Croce in camicia grigia: disse «sì» al regime ma soltanto per timore dell’ascesa rossa
di Corrado Ocone - Il Mattino 2021.02.17
Quando Croce restò sedotto dal fascismo
di Ugo Cundari - giornaledistoria.net 2021.02.12
Tra pensiero e azione: Benedetto Croce nel ventennio fascista
di Marcello Rinaldi - Il Quotidiano del Sud 2021.02.07
Il rapporto tra Croce e il fascismo. Radiografia senza semplificazioni
di Luigi Morrone - letture.org 2021.02.04
“Benedetto Croce. Gli anni del fascismo” di Eugenio Di Rienzo - La Repubblica 2021.02.01
Croce e il fascismo una storia italiana
di Aurelio Musi - lanostrastoria.corriere.it 2021.01.29
Benedetto Croce davanti al fascismo
di Gerardo Nicolosi