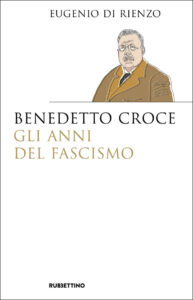Prof. Eugenio Di Rienzo, Lei è autore del libro Benedetto Croce. Gli anni del fascismo edito da Rubbettino: quale importanza rivestono gli anni del fascismo per la biografia politica del filosofo?
Di fondamentale importanza fu l’esperienza del fascismo per l’itinerario intellettuale del filosofo. Soltanto in seguito al suo passaggio da convinto simpatizzante del movimento mussoliniano (considerato l’unico ingrato rimedio allo stato di anarchia permanente che soffocava il nostro Paese), a inflessibile oppositore del regime, la sua riflessione politica, che aveva a lungo oscillato tra la lezione di Marx, una tiepida e fuggevole simpatia per l’ideologia socialista, il pensiero anti-sistema di Georges Sorel, il legato dei teorici tedeschi dello «Stato potenza», come Heinrich von Treitschke ebbe, soprattutto nel decennio 1928-1938, la sua svolta decisiva.
Solo dopo il successivo ritorno, dopo la Grande Guerra, alla piena accettazione della versione autoritaria del liberalismo ottocentesco mutuata dall’eredità della Destra storica, il pensiero di Croce, infatti, iniziò a chiarirsi, a far data dalla metà degli anni Venti, nei suoi tratti distintivi per dare luogo a un «nuovo liberalismo». Sarebbe stato quello un liberalismo diverso da quello del «mondo di ieri», per dirla con Stefan Zweig, ma proprio per questo in grado di fronteggiare la sfida dei totalitarismi del Novecento (quello fascista e quello comunista), diversi nelle loro premesse ideologiche ma egualmente avversi al vivere civile delle società occidentali, alle loro istituzioni politiche e alla loro tavola di valori morali. Molto prima della comparsa del volume di François Furet, Le passé d’une illusion, edito nel 1995, Croce, infatti, aveva compreso perfettamente che se tutti i liberali, tutti i democratici e molti conservatori, durante la dittatura del fascio littorio e della svastica, furono antifascisti, non tutti gli antifascisti, in quello stessa congiuntura storica, furono liberali o democratici.
Croce fu davvero «uno schietto fascista senza camicia nera», come gli rinfacciò Giovanni Gentile?
La definizione di Gentile, pur pronunciata nel pieno della polemica, che lo oppose a Croce nel maggio del 1925, contiene un elemento di verità. Quella definizione, infatti, evidenziava il sostanziale «equivoco» che, sbagliando ogni calcolo, indusse Croce e i liberali a vedere nel capo del fascismo l’uomo che, dopo aver sconfitto la minaccia della rivoluzione bolscevica, si sarebbe ritirato nell’ombra, come un «nuovo Cincinnato» (il paragone fu avanzato da un altro liberale, Gaetano Mosca), pago di aver ripristinato «il normale funzionamento del sistema rappresentativo così come era accaduto a Roma nei migliori tempi della Repubblica, quando qualche volta, per la salvezza della patria, si ricorreva, per brevi periodi, alla dittatura provvisoria».
Questa disposizione di Croce nella fase della scalata al potere di Mussolini fu, infatti, anche di altri intellettuali, vicini all’ideologia liberale, se si pensa ad economisti come Maffeo Pantaleoni, Einaudi, Umberto Ricci, Alberto De Stefani, che fu ministro delle Finanze di Mussolini nel 1922 e che puntò ad una liberalizzazione dell’economia italiana, suscitando il favore di Luigi Einaudi. Lo stesso Einaudi che avrebbe visto nel fascismo il potente maglio capace di abbattere il conglobato improduttivo degli antichi e dei novissimi interessi costituiti, non senza risparmiare parole di lode rivolte ai «giovani ardenti, in camicia nera, che chiamarono gli italiani alla riscossa contro il bolscevismo», i quali avevano riportato la vittoria nella contesa ingaggiatasi «tra lo spirito di libertà e lo spirito di sopraffazione».
Certo, non mancarono, sin dagli esordi dell’avventura mussoliniana, anche in area liberale, le voci discordanti e premonitrici dell’avvento della dittatura – come quelle di Giustino Fortunato, Giuseppe Antonio Borgese, Guido Dorso, Luigi Albertini, Ugo Zanotti Bianco e di altri happy few – ma la frase di Gentile, riferita a Croce, restituisce bene quella che in casa liberale era una convinzione largamente condivisa. Non bisogna dimenticare, infatti, le dichiarazioni, a questo riguardo, formulate dal primo Segretario generale del Partito Liberale, Quintino Piras nel 1924. A proposito del programma varato nel 1922 al primo Congresso di Bologna del Pli, in cui al primo punto vi era la «restaurazione in Italia dell’autorità dello Stato», Piras si esprimeva, infatti, in questi termini: «Perché negarlo? Eravamo forse più fascisti dei pochi fascisti di allora – se per fascismo si intendeva l’unione degli animi che volevano forte e rispettata nel mondo una Italia i cui figli fossero fratelli e non nemici, un’Italia in cui il tranquillo lavoro fosse la fonte di ogni benessere economico e sociale».
Come e quando maturò il filosofo il suo passaggio a inflessibile oppositore del regime?
Per arrivare a cogliere compiutamente, le fattezze del «Croce oppositore», per usare il titolo di un articolo di Gobetti, bisognerà arrivare gli inizi del 1925. Ma per avere veramente chiara la fisionomia del definitivo maturarsi del liberalismo, del direttore de «La Critica» che ora lanciava il suo guanto di sfida al fascismo, forte di un’amara consapevolezza sui rischi della politica della forza, pur senza deporre le armi del suo antico Politischer Realismus, occorrerà aspettare il compimento di un più lungo e tortuoso percorso. Percorso che andrà dalla Storia d’Italia dal 1871 al 1915 del 1928 alla Storia d’Europa nel secolo decimonono del 1932, per arrivare alla meta finale con La storia come pensiero e come azione del 1938.
Tappa intermedia ma fondamentale di questo complesso itinerario sarà, comunque, il 1931, data di pubblicazione di Etica e politica. In quel volume, infatti, dove pure era ricompreso il saggio del 1922, nel quale Croce aveva riaffermato che «gli Stati somigliano alle cosiddette forze della natura che l’individuo etico dirige e attualizza ma non crea», trovava posto anche un ben diverso contributo. Si trattava dell’articolo, Storia economico-politica e storia etica politica, apparso su «La Critica» del 1924, dove Croce insisteva sul carattere effimero e provvisorio dell’organismo statale in quanto ente sottoposto al continuo processo di trasformazione provocato dalla dinamica storica e dal progresso morale dell’umanità.
E a quella nota sarebbero seguiti altri interventi di analogo tenore, con i quali il filosofo, prendeva, con nettezza, le distanze dall’Historismus di Friedrich Meinecke e da Ernst Troeltsch. Due studiosi che, rifiutando la possibilità di tradurre «l’astrazione dello Stato nella realtà di un determinato avvenimento o momento storico», in modo da individuarvi l’agire della coscienza morale «nella concretezza delle sue singole volizioni e azioni» avevano, forse, attualizzato ma non superato la lezione di Treitschke. Era quella una lezione che, Croce, invece, sembrava, ormai, voler archiviare (seppur, come avrebbe osservato, poi, Carlo Antoni, dopo lungo un cammino sofferto, contrastato e forse mai del tutto compiuto), subordinando le pur vincolanti ragioni dell’«egoismo politico» e della «cruda realtà della politica come conflitto e come violenza» alla libertà della coscienza individuale, già nel saggio del 1925 paradigmaticamente intitolato Libertà e dovere.
Certo Croce, in questo momento, era ancora lontano dal sostenere, come avrebbe fatto, tra 1932 e 1938 che le teorie dello «Stato Potenza» partorite dalla cultura tedesca, e la ripresa ipernazionalistica, nella Germania nazista, della dottrina hegeliana dello Stato etico avevano giocato una grande parte «nell’invelenire i conflitti dei popoli, contribuendo alla distruzione e allo sconvolgimento della civiltà mondiale». Sicuramente, la posizione del filosofo non era ancora, alla metà degli anni Venti, radicalmente mutata da quella espressa nel 1911, quando aveva riconosciuto che un’indebita estensione del «culto della libertà» che comprendesse in esso anche la difesa delle aspirazioni del democraticismo, trovando un forte ostacolo alla possibilità di essere correttamente definita «in termini razionali» e rischiando di essere mistificata come servo encomio «all’utilitarismo borghese e socialistico», aveva la sua ragion d’essere soprattutto, e forse unicamente, in un istintivo moto ideale e in un afflato di carattere religioso, entrambi afferenti alla sfera della metapolitica e non della politica propriamente detta.
Eppure la densa nota, Libertà e dovere, segnava un deciso momento di passaggio verso una concezione piena e compiuta della libertà, considerata come principio generale ed eterno della vita morale e civile, che poteva riformularsi in termini di concrete proposte istituzionali, economiche, sociali, politiche dove liberalismo e democrazia, anche nella sua variante laburista, dovevano, almeno temporaneamente avvicinarsi, pur senza confondersi, e addirittura allearsi contro il comune avversario, per tutelare la loro sopravvivenza. Quell’intervento di forte impatto preludeva direttamente, al contributo del 1927, La concezione liberale come concezione della vita, i cui temi avrebbero poi avuto glorioso epilogo, tre anni, dopo nella relazione, Antistoricismo, presentata al settimo Congresso Internazionale di Filosofia di Oxford il 3 settembre 1930. Un intervento la cui lettura folgorò letteralmente Thomas Mann, nei punti dove Croce avanzava, per la prima volta, il tema della «religione della libertà» e del «senso storico come civiltà e cultura» come unici antidoti al culto «della forza per la forza».
Non bisogna dimenticare, infatti, che, se il magistero di Croce fu, fino al 1943, il polo più forte e più autorevole, se non addirittura il solo, se si escludono i deboli conati della resistenza cattolica e comunista, attorno al quale si raccolse l’emigrazione antifascista interna, quel magistero influenzò fortemente, nella loro lotta alle dittature, anche grandi intellettuali europei come Karl Vossler, Leo Spitzer, Albert Einstein, il diplomatico e pubblicista croato, Bogdan Radica e a molti altri “chierici”, oppugnatori dell’ondata totalitaria che si stava estendendo nel Vecchio continente.
Quale giudizio storico espresse Benedetto Croce sul fascismo dopo il 25 luglio 1943?
In un suo intervento, Giuseppe Bedeschi ha insistito sulla validità della definizione del fascismo come breve e transeunte «parentesi» della vita politica italiana, priva di ogni nesso di continuità con la storia dell’Italia liberale, formulata a più riprese da Benedetto Croce dopo il 25 luglio 1943. E lo ha fatto in una critica a quanto sostenuto nel mio volume, Benedetto Croce. Gli anni dello scontento 1943-1948, sempre pubblicato da Rubbettino nel 2019. Lì, affermavo, concordando con le tesi di Federico Chabod, Giuseppe Galasso, Gennaro Sasso, Roberto Vivarelli, che quella formula, «falsissima in sede storiografica» avrebbe detto Eugenio Garin, andava intesa alla stregua di uno slogan strumentale (un vero e proprio «uso politico della storia»), adatto al tempo e all’ora, quando l’Italia Nazione armistiziata, in attesa di una pace punitiva, doveva relegare il Ventennio nero, tra gli «accidenti della storia», per ottenere una condanna più mite da parte dei vincitori.
Detto questo, ciò che comunque deve essere ricordato è che la lettura del fascismo «come fase effimera, non prevedibile e come avventura estranea alla storia italiana», pur inidonea a fornire un contributo alla definizione storiografica del fascismo come evento storico, non fu, però, «un giudizio polemico di ritorsione», come scrisse Chabod nel 1950. Né quell’interpretazione fu, certo una tesi di comodo, costruita a uso personale, o un argomento da riportare al supposto ottimismo storico (naturalmente, idealistico) di Croce. Fu, invece una scelta sofferta del suo tormentato itinerario biografico, assunta, non senza travaglio, nell’ostile realtà di un tempo ferrigno che aveva lasciato il segno anche nell’hortus conclusus dell’autonomia della speculazione storica.
In che modo la riflessione crociana sul regime ha condizionato la successiva storiografia?
Anche dopo il 25 aprile 1945, rimase in Croce qualcosa di non detto, d’irrisolto nel suo approccio alla storia del fascismo, di cui resta traccia nella conversazione, L’obiezione contro le “storie dei propri tempi”, tenuta agli alunni dell’Istituto di Studi storici di Napoli nell’anno accademico 1949-1950. In quella lezione, l’anziano maestro riferiva, ai futuri analisti del passato, destinati a operare nell’Italia repubblicana, della sua invincibile repulsione a cimentarsi in una ricostruzione storica del fascismo che lo avrebbe obbligato «a mettermi a contemplare e indagare uomini e fatti a me odiosi e ripugnanti e fastidiosi verso i quali non solo non provavo la vile gioia della vendetta, ma non mi era lecita gioia alcuna perché essi si legavano al danno e all’onta, a me amarissima, della mia patria, illusa, tradita, offesa, vituperata».
Si è detto, giustamente, che un simile invito alla rimozione del passato provocò il perverso risultato di bloccare sul nascere, per molti anni, la possibilità di un’analisi del fascismo come «problema storiografico», con non piccolo nocumento alla crescita civile della società italiana. E questa è constatazione difficilmente oppugnabile, a patto di ricordare, però, che anche Togliatti, dopo le lezioni moscovite sul fascismo del 1935, ritornato in Italia e assunte, nel nostro Paese, responsabilità di partito e di governo, non ritornò sul progetto di un’organica analisi della dittatura in camicia nera. Il «Migliore», allora, volse invece la sua attenzione verso altri periodi della storia d’Italia e in particolare a quell’età giolittiana che, concordemente a Croce, valutò molto positivamente «come il decennio di massimo benessere, di relativa tranquillità, di stabile equilibrio delle forze, di apertura verso il movimento socialista», prima del fatale agosto 1914 e dell’insorgere del conflitto che aveva posto fine alla Belle époque liberale.
Altre Rassegne
- francescomacri.wordpress.com 2021.03.04
Storia del Novecento. Fascisti e antifascisti contro Benedetto Croce
di Franco Cardini - Avvenire 2021.03.03
Fascisti e antifascisti contro Don Benedetto
di Franco Cardini - indygesto.com 2021.02.25
Quando Croce appoggiò il fascismo - Il Giornale 2021.02.20
Croce in camicia grigia: disse «sì» al regime ma soltanto per timore dell’ascesa rossa
di Corrado Ocone - Il Mattino 2021.02.17
Quando Croce restò sedotto dal fascismo
di Ugo Cundari - giornaledistoria.net 2021.02.12
Tra pensiero e azione: Benedetto Croce nel ventennio fascista
di Marcello Rinaldi - Il Quotidiano del Sud 2021.02.07
Il rapporto tra Croce e il fascismo. Radiografia senza semplificazioni
di Luigi Morrone - letture.org 2021.02.04
“Benedetto Croce. Gli anni del fascismo” di Eugenio Di Rienzo - La Repubblica 2021.02.01
Croce e il fascismo una storia italiana
di Aurelio Musi - lanostrastoria.corriere.it 2021.01.29
Benedetto Croce davanti al fascismo
di Gerardo Nicolosi