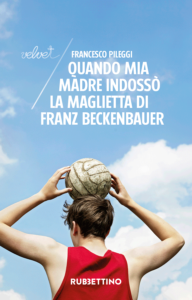Il titolo, sia stato esso trovato dall’autore o da un editor, frutto dei conciliaboli tra questi o con altri soggetti della catena editoriale, è uno dei più lunghi mai inventati per un romanzo.
Il motore narrativo sia avvia fondamentalmente con la partita di calcio giocata il 17 giugno 1970 dalle nazionali italiana e tedescoccidentale allo stadio Azteca di Città del Messico nella quale, al 65° minuto, Franz Beckenbauer (costruttore di invasi d’acqua, secondo l’onomastica tedesca) si infortunò alla spalla; non potendo l’allenatore fare altre sostituzioni, il mediano continuò a giocare fino alla fine con una fasciatura che gli legava il braccio al petto: «regale e stoico nel suo non mollare» (Fernando Acitelli dixit).
Il calcio sembra dunque il tema fondamentale, declinato sia nell’olimpo delle grandi competizioni e che nella microstoria paesana; ma, dietro l’apparenza e intrecciati con essa, scorrono i grandi problemi del mondo (dittature militari sostenute e incoraggiate dagli USA in Cile e in Argentina, lavoro minorile, disfunzioni scolastiche. Emigrazione) e quelli riassunti nel paese calabro che fa da quinta alla vicenda narrata.
Partiamo dai mondiali di calcio del 1978 in Argentina nei quali nessun esponente dell’infregolato mondo calcistico ebbe il coraggio di contrastare il disegno dei generali golpisti: quello di silenziare, negli strombazzamenti e nelle urla degli stadi, le grida strazianti dei giovani desaparecidos lanciati nell’oceano da aerei militari nonché i singulti degli strangolati nelle scuole dell’esercito.
Nessuno dei pallonari protagonisti della scena mondiale si oppose a quel disegno di Jorge Videla & company; con un’eccezione però:
«Fu più o meno l’unico stronzo Paul Breitner, giocatore della Germania dell’Ovest, a stare dalla parte delle madri di Plaza de Mayo. Non voleva far finta di niente, anzi sperava che altri compagni di squadra non partecipassero, sperava che la sua nazione per prima rinunciasse, convincesse le altre. Fu solo una speranza. ….Diede l’esempio che non fu preso da esempio, ma lui lo divenne un Esempio, per pochi ma lo divenne» (pp. 28-29).
Protagonisti del romanzo sono otto ragazzini di un paese situato lungo la direttrice Lamezia Terme-Catanzaro lido che, oltre ad essere il tratto più stretto dello Stivale, è anche sovrapponibile all’isoglossa che, secondo Gerard Rohlfs, divide in due l’antica terra dei Bruzi: al Nord la Calabria dal «cappello pizzuto», debitrice della lingua latina, e al Sud la Calabria dalla «barritta longa», tributaria della lingua greca.
La stessa direttrice avrebbe percorso, ma l’autore segue tracce più o meno oniriche e quindi spesso inverosimili anche dal punto di vista letterario, un gruppo di compagni dell’ἀγκυλομήτης Ulisse incaricati di portare a spalla sui liti jonici la loro imbarcazione; uno stratagemma, quello di apparire un naufrago, per essere accolto con premura da Nausicaa e dalle altre donne feaci (pp. 97-100 e 121).
La fonte? Un maestro elementare dalla bacchetta facile che raccontava di come la stravagante compagnia odissiaca fosse passata proprio «sotto casa nostra»; e il narratore, incredulo, aggiunge: «Riuscivo a vedere Ulisse ma non riuscivo a vedere , allora, i Proci sulla mia terra. E non mi chiesi neppure perché mio padre e non solo il mio avessero lasciato mia madre Penelope e tutte le altre» (p. 16-17).
La vita quotidiana dei protagonisti era stretta dunque, da una parte, fra l’assenza dei padri per emigrazione in paesi nordeuropei e l’apprendistato più vario («Ognuno di noi passava il suo tempo a guadagnare le sue cento lire a settimana dopo la scuola. Barbiere, fruttivendolo, barista, salumiere, falegname, meccanico, muratore, tappezziere, sarto, calzolaio … non c’era mestiere a cui le nostre madri non ci spedivano» p. 38) e, dall’altra, le lezioni elargite dal sunnominato maestro Pietro.
Una pièce teatrale sembra a tratti il romanzo con la fabula che include, oltre al rammemorato incontro di Città del Messico, «Partido del Siglo», passaggi importanti sul mondiale di calcio del 1978 in Argentina nonché una cronaca molto sui generis di una partita di calcio fra due squadre di ragazzi del paese.
In quest’ultima gli otto protagonisti decidono di scendere in campo tutti quanti con la maglia n 4 della Germania occidentale, quella che vestiva Franz Beckenbauer a Città del Messico nella famigerata partita.
I fornitori di alcune divise furono i genitori immigrati nel Nordeuropa, anche in Germania; chi accondiscese a quella strana richiesta lo fece non senza perplessità e solo su intercessione della moglie.
Il primo a riceverla quella maglietta fu l’io narrante, «il figlio di Nina, quella che lavora nella latteria sul corso» p. 76) che nella serata del 17 giugno 1978 aveva rischiato di prendere le botte da un paesano solo perché non ne aveva condiviso l’odio antigermanico diffuso e sostenuto da chi guardava la partita al bar dello sport.
I più tra i padri emigrati risposero picche anche perché ricordavano come, dopo la partita all’Atzeca, avevano dovuto serrarsi in casa per evitare di essere linciati dalla folla di tifosi alemanni: questi, in preda al livore per la sconfitta della loro squadra, avevano scatenato il demone del razzismo che sonnecchiava nei loro interna corporis ed era tenuto a malamente a bada dall’ormai lontano 25 aprile 1945:
- «Cara moglie digli che si preparasse la valigia che quando scendo me lo porto con me a lavorare nella miniera, con la maglietta n. 4 del Belgio …. » (p. 76)
- «Cara moglie, digli che qui a Francoforte, i tedeschi dopo la partita le macchine ci incendiarono e a due dei nostri che festeggiavano con la bandiera italiana, a calci e pugni li hanno presi e per paura non siamo usciti di casa il giorno dopo, neppure per andare a lavorare …» (p. 76-77).
- « … quella di Rivera gli compro, quando torno … se la vuole» (p. 77)
Chi non l’aveva ricevuta dal padre, quella maglia n. 4, l’aveva rimediata dalle madri che si intendevano di sartoria: alla fine la partita si svolse sotto la direzione di un arbitro che, non disponendo nemmeno della moneta per fare scegliere il campo col testa-croce, ricorse due distici del folclore dialettale usati come l’ambarambacicicocò.
La tiritera è diffusa in tutta la Calabria e la variante usata dall’arbitro faceva fare una brutta fine alla gatta (coprotagonista della fabula assieme al «surici») che vi moriva (in quella del mio paese, ad esempio, «si rimuoveva» soltanto).
Alla fine i nostri eroi (scambiati per nazisti, capitalisti o … ebrei, pp. 82-83) vennero assaltati dagli avversari, anche tifosi, che tutte le lacerarono quelle povere magliette beckenbaueriane … e finirono «cornuti e mazziati»
Ma, come in ogni sfida che si rispetti, ci fu la rivincita; o forse no, quella «rijuta» (che sarebbe «il ritorno» perché veniva dopo la «ijuta», l’andata cioè) in cui le mamme dei nostri otto eroi intervennero per sostenere e difendere «manu armata» i loro figli ed anche tutelare il loro onore (tutte meno una, che non avendo onore da tutelare dedicò tutte le sue forze alla difesa armata) molto probabilmente fu un sogno ricorrente degli sconfitti; anzi un incubo in cui tutte le amarezze vissute nell’unica partita giocata ricorrevano a inquietare le loro albe di studenti svogliati e feriti. Oppure, come diceva un moravo vissuto a Vienna e morto a Londra dal cognome significante «gioia» (Un nazista? Un capitalista? Un ebreo?), quel sogno era la realizzazione surrogata di un desiderio o, meglio, una esperienza reale dell’immaginario.
Seguendo Dorian Gray, abbiamo parlato dell’opera d’arte e taciuto dell’artista: a lui, per ora, un augurio di buon viaggio nella letteratura.