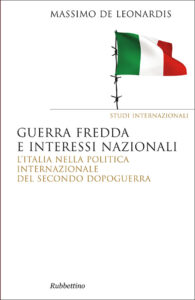Da Libero del 27 agosto
Da Libero del 27 agosto
Può sembrare strano parlare di politica estera italiana negli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda guerra mondiale, quando un’Italia pesantemente sconfitta, con decurtazioni territoriali e senza più colonie, e il mondo diviso in due blocchi sembrano allontanare i problemi internazionali dallo scenario politico italiano, concentrandoli piuttosto sullo scontro tra libertà occidentale e dittatura comunista.
Invece, non troppo paradossalmente, fu proprio l’immediato secondo dopoguerra che fece tornare d’attualità la politica estera, per decenni confinata a conseguenza di quella interna.
Salvo la parentesi del fascismo (e, per altro, il discorso non vale neppure per tutto il regime), la storia dell’Italia unita fu una storia essenzialmente rivolta a ciò che accadeva a casa propria e anche le scelte di politica estera furono spesso motivate da esigenze di carattere interno (si pensi, per fare un solo esempio, alla giolittiana guerra di Libia). Lo sottolinea Massimo de Leonardis in un acuto volume, Guerrafredda e interessi nazionali. L’Italia nella politica internazionale del secondo dopoguerra (Rubbettino, pp. 354, euro 20), ponendosi alla ricerca delle linee che i governi e la diplomazia italiana perseguirono per tutelare gli interessi nazionali.
Il banco di prova fu Trieste (ben più delle colonie), la cui sorte sembrò subito segnata. De Leonardis illustra con dettagli anche inediti come l’Italia sia arrivata al Trattato di pace del ’47 e quanto abbiano influito sia le preoccupazioni elettorali sia una mentalità lontana dagli interessi nazionali. In particolare, proprio la diplomazia che sostanzialmente era rimasta quella fascista, certamente nutrita di miti nazionalistici – fu quella che maggiormente cercò di dimostrare come l’Italia avesse superato la fase fascista e imperialista. In questo senso la maggior parte dei diplomatici fu convinta che l’avere rotto nel ’43 con il fascismo e avere combattuto a fianco degli Alleati costituisse quella “redenzione” dal male che avrebbe consentito all’Italia un trattamento meno pesante in sede di trattative per la pace.
A ciò si aggiunga una diffusa mentalità ecumenico-internazionalista nei tre principali partiti di governo: strumentale quella comunista, in realtà finalizzata a sostenere le ragioni dell’Urss o dei suoi alleati; vetero internazionalista quella socialista; convinta quella cattolico-progressista, nell’ottica di un superamento totale delle logiche nazionali.
La situazione di Trieste peggiorò, per l’Italia, dopo la firma del Trattato di pace e soprattutto dopo il divorzio tra Stalin e Tito: il maresciallo jugoslavo divenne una sorta di figliuol prodigo degli Usa e degli Alleati. Avendo abbandonato la logica del blocco sovietico, Tito fu assecondato in ogni occasione e si cercò di sostenerlo economicamente, militarmente e territorialmente.
Una situazione per noi senza via d’uscita, soprattutto perché la diplomazia italiana (e De Gasperi) avevano cercato di ottenere il più possibile su Trieste dimostrando che in realtà non era per l’Italia ma per l’Occidente minacciato da Mosca. Un argomento, dopo lo strappo di Tito, non più utilizzabile, anzi in grado di ritorcersi contro gli interessi italiani.
De Leonardis dimostra, a tal proposito, quanto invece sia stata più utile alla causa italiana la posizione dura e reattiva di Pella, il capo del governo che non esitò a inviare truppe al confine jugoslavo dopo le provocazioni titine nell’autunno del 1953.
In quell’occasione gli Usa si accorsero che l’Italia esisteva e che forse gli Alleati si erano spinti troppo verso Belgrado. Fu anche questo il motivo che permise il ritorno di Trieste all’Italia nel novembre dell’anno successivo.
Ma quella di Pella fu un’eccezione. La politica estera italiana fu sempre segnata dall’ambiguità, riassunta, qualche anno più tardi, nella furbesca formula del «neoatlantismo», che significava essere formalmente alleati degli Usa, ma poi comportarsi in maniera difforme, con la scusa di gettare ponti verso l’Est. E questo non giovò all’immagine presso gli Alleati, i quali preferivano durezza chiara piuttosto che buonismo ambiguo.
di Giuseppe Parlato
Clicca qui per acquistare una copia del volume con il 15% di sconto
Altre Rassegne
- RSPI 2014.12.11
Recensioni e segnalazioni
di Giorgio Bosso - Libero 2014.08.27
La politica estera italiana sotto il segno dell’ambiguità da Trieste al neoatlantismo
di Giuseppe Parlato